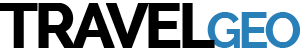Anatolia Kurdi

Dal corso superiore del fiume Eufrate fino al confine con la Turchia ed Iran si estende l’ Anatolia Orientale, nota nell‘antichità come Armenia, una vasta regione aspra montuosa dominata ad est dalle vette del Buyk Agri Dogi (5165n) e Kùciik Agri Dogi (3925 m) appartenenti al biblico massiccio dell’Ararat dove la leggenda vuole che si fermò l’ arca di Noè dopo il Diluvio.Il popolamento della Turchia orientale è ancora più antico dei testi sacri ebraici e fu uno dei primi territori dove si svilupparono camunità umane organizzate, una delle prime “culle di civiltà’ della storia e da sempre contesa tra l’Asia persiana e l ‘occidente.Dopo l’invasione delle popolazioni in indoeuropee, che determinarono la caduta dello Impero Hittita nel XII sec. a.C., vi fu un lungo periodo in cui l ‘Anatolia fu popolata da gruppi etnici sia indoeuropei che asiatici molto diversi tra loro ma che, tuttavia, svilupparono una cultura originale dai tratti comuni che venne poi soppiantata durante il periodo ellenistico prima e romanobizantino poi e della quale esistono poche testimonianze archeologiche e culturali.L’ Anatolia diventò un’ importante regione strategica tra l’oriente e l’occidente contesa prima tra greci e persiani, poi tra romani e parti, infine tra bizantini e sassanidi, fino al l’invasione dei Turchi Selgiuquidi nel XI secolo che vi introdussero la religione islamica e ne mutarono ancora una volta la composizione etnica e culturale.
Storia e tradizioni
In questo lunghissimo periodo di invasioni, guerre, radicali mutamenti culturali e religiosi, alcune popolazioni originarie delle zone più isolate e meno accessibili, riuscirono a conservare parte delle antichissime tradizioni tribali indoeuropee che integrarono a quelle introdotte attraverso i secoli all’ islamismo penetrato tra le montagne anatoliche nel medioevo. Alcune di queste antiche tradizioni hanno influenzato anche le popolazioni turche insediatosi in Anatolia dopo l ‘invasio ne dei Selgiuqidi con la creazione di sette religiose islamiche come quelle dei Bektasi, RIfa’ t, Naqsbendi e Nulevi, che riprendevano alcuni culti persiani basati su riti estatici pagani in netto contrasto con le regole mussulmane e duramente cambattute in Turchia dai tempi dell’ impero ottomano fino ad oggi.Altre tradizioni sono soprvvissute tra le gran di tribù anatoliche cane quella dei Juruki, nomadi dell’est che conservarono molti culti pagani sebbene convertiti da secoli all ‘islamismo sciita, è anche il caso dei Takritaget che probabilmente discendono dalle prime popolazioni indoeuropee, convertiti anch’essi all’ islamismo sciita e che hanno integrato a credenze e riti magico religiosi pagani. Vi è infine la tribù dei Kizilbasi, la cui setta “AltIlahi” sembra essere una sintesi delle varie credenze introdotte in Anatolia fin dai tempi più antichi, dal paganesimo persiano all’ islamismo e il cristianesimo, delle quali la manifestazione più evidente è la loro concezione della divinità came trinità e il particolare culto della Vergine Maria che, assieme a regole islamiche, si serve di una specie di ecaurestia del pane e del vino consumata con l ‘accompagoamento di musiche e canti tribali a luci spente, per cui sono chiamati dalle altre popolazioni “grraksòndiiran” “spegnitori di luci”.
I Kurdi
In questo panorama di “soprawivenza culturale”, la popolazione che più di ogni altra “riuscita a conservare gran parte delle caratteristiche originarie è quella dei Kurdi che vivono, oltre che nell’ est della Turchia, anche nelle confinanti regioni della Gesiria in Siria, l’ Armenia, il nord dell’ Iraq, l‘ Azerbagian, il Kurdestan e il Ker manshahan in Iran.Probabilmente i Kurdi discendono dalla potente tribù guerriera indoeuropea dei Kardukai, le cui prime tracce risalgono ad iscrizioni sumere ed assire e più tardi menzionata varie volte da conisti greci del V0 e IV0 sec.a.C., attualmente hanno perso la tipologia originaria con secoli di incroci con le popolazioni arabe, armaiche e turche che abitano nelle varie zone che compongono il Kurdistan e dalle quali hanno adottato came seconda lingua l’arabo, il persiano o il turco, mentre quella principale resta il kurdo, del gruppo indoeuropeo, con i suoi tre dialetti principali Zaza, Gourani e Kenrani, considerato quello letterario ed ufficiale.Gran parte dei kurdi sono diventati agricoltori sedentari e la loro esistenza non sembra differenziarsi da quella delle altre popolazioni orientali anatoliche, vivono in piccoli villaggi nelle zone più isolate tra le montagne, costituiti da semplici abitazioni di legno o graticcio ricoperto di fango con due sole stanze, il “selamik” e l’ “harem”, con soppalchi per dormire, un armadio chiamato “dolap” e qualche cassa, i “sandik”, dove ripongano i pochi beni di famiglia.Nei terreni ricavati faticosamente dall’ aspro territorio delle vallate coltivano soprattutto grano, orzo e tabacco, pochi ortaggi e cotone, servendosi ancora di strumenti arcaici come i semplici aratri trainati da bovini o spinti dai contadini; le falci per la mietitura, gli attrezzi per la trebbiatura e i sistemi di irrigazione sono spesso simili a quelli raffigurati nei bassorilievi sumeri ed assiri. Ogni villaggio è autosufficiente con la sua produzione agricola, i capi di bestiame e l’ artigianato che coprono il fabbisogno della comunità, regolata dalle antiche leggi tribali e saldamente legata alla propria identità in un mondo arcaico simile a quello dell’antica Mesopotamia.
E’ solo un impressione superficiale che la presenza di molti elementi “moderni” e, a volte, le armi automatiche portate dagli uomiini in alcuni zone riconduce ad una realtà “difficile” e drammatica nella quale i kurdi sono costretti da secoli per difendere la loro identità.In queste zone più isolate del Kurdistan, dove difficilmente i militari osano avventurarsi, è in parte sopravvissuto l’antico ordinamento feudale medioevale nel quale i discendenti dell‘ aristocrazia guerriera hanno diviso le loro vaste proprietà in tanti appezzamenti affidati ad affittuari ai quali va la metà della produzione.
La società tribale
Sia per gli agricoltori sedentari che per gli allevatori nomadi, l’organizzazione tradizionale della società kurda è la stessa, basata sulle confederazioni tribali “ashirat”, ciascuna delle quali è suddivisa in vari clan o “tira”, i cui componenti possiedono un antenato in comune e sono legati tra loro da “vincoli di sangue”, anche se vivono separati in differenti tribù o villaggi. A sua volta ogni “tira” è suddivisa in più gruppi di famiglie o “khel”, che vivono nella stessa canunità tribale e al cui interno ogni famiglia si considera indipendente, composta dal capofamiglia con una o più mogli e a seconda delle possibilità econoniche, i figli e a volte dei servi. Ogni “Khel”, “Tira” e “ashirat” è governata da un capo “agha” appartenente all’ aristocrazia guerriera, ma mentre tra gli agricoltori sedentari degli “agha” sono i proprietari più ricchi che si tramandano la carica e, tra gli allevatori nomadi vengono eletti da un consiglio tribale tra i più abili ne gli spostamenti e nella ricerca delle zone di pascolo, a volte scelti anche tra le donne. Nonostante l’ islamizzazione e la discendenza tribale “patrilineare”, infatti, nella società tradizionale kurda la donna gode di notevole libertà rispetto a tutte le altre popolazioni nusulmane dell’ Asia minore, caratteristica probabilmente risalente alla più antica organizzazione tribale indoeuropea dalla quale discendono alcuni elementi di quella kurda. In questo ordinamento sociale il ruolo della famiglia è considerato essenziale e tutta una serie di convenzioni ed usanze ne garantiscono la salvaguardia dell‘ unità, compresi i matrimoni che vengono generalmente effettuati tra i figli di due fratelli o cugini per rimanere la proprietà della nuova coppia nell’ ambito della stessa famiglia o clan, è anche diffuso lo scambio delle sorelle cane spose tra gli appartenenti allo stesso “khel”. In ogni caso i matrimoni debbono avvenire nel l’ambito della medesima comunità e raramente tra membri di due villaggi diversi, anche se la poligamia è permessa è molto difficile che un uomo possieda più di una moglie, dati gli alti costi necessari al pagamento di una sorta di “risarcimento” previsto per i genitori della sposa e, soprattutto, al mantenimento di più mogli. Solo ai proprietari terrieriri e agli “agha”, è permesso di prendere moglie fuori dal proprio gruppo, soprattutto per stabilire nuovi vincoli di parentela ed alleanze tra famiglie aristocratiche di clan o tribù diverse, e praticamente sono gli unici poligami tra i kurdi, potendo disporre delle ricchezze necessarie per mantenere più mogli.La struttura sociale dei kurdi, sia di quelli sedentari che dei nomadi, appare tutt’ ora come un complesso di raggruppamenti famigliari, clanici e tribali, ognuno dei quali possiede le proprie leggi che ne regolano i rapporti all’ interno e nelle relazioni con le altre entità, basate essenzialmente sui “vincoli di sangue” e la solidarietà clanica o tribale derivati dall ‘antica tradizione guerriera, il cui mantenimento ha permesso la continuità cultura le di questo popolo fino ad oggi, nonostante le costanti pressioni e minacce esterne cui è stato fatto oggetto.In passato tali raggruppamenti erano spesso in lotta tra loro e l’uso delle razzie tra villaggi e tribù diverse, comune a molte altre popolazioni di origini nomadi, contribuivano ad una situazione di perenni conflitti intertribali o feudali che, tuttavia, venivano sempre interrotti per far fronte comune a tutte le minacce esterne che, proprio per questa perenne caratteristica “guerriera” e bellicosa dei kurdi, non sono mai riuscite il completo sopravvento su un popolo solo apparentemente frazionato e diviso. I violenti conflitti intertribali sono da tempo terminati, anche tra le tribù più isolate per le quali attualmente la minaccia dei turchi o gli iracheni è sempre stata costante e drammaticamente precipitata con il sorgere del mostruoso “stato islamico” e dei barbari tagliagole dell’Isis contro i quali solo i Kurdi sembrano tenere fieramente testa.
Tra Islam e Tradizione
I kurdi possiedono caratteristiche proprie ed originali anche nel loro islamismo, sunnita in Turchia e Siria, ma con maggioranze sciite in Iraq ed Iran, differenziandosi notevolmente dai loro correligionari per la presenza di varie influenze preislamiche quali antiche credenze tradizionali, vecchi culti iraniani, concezioni settarie medioevali e pratiche di origine cristiana. La stessa casta religiosa, che in alcune zone possiede una certa influenza politica, svolge funzioni spesso differenti da quelle specificamente coraniche e il suo ruolo nell ‘ambito tribale è determinato essenzialmente dalla saggezza, la conoscenza della tradzione e delle antiche pra tiche esorcistiche, le relazioni che i religiosi riescono a stabilire con i vari elementi del la struttura sociale tradzionale e, soprattutto, con gli “agha” e i proprietari terrieri. Al vertice di questa casta religiosa stanno gli “shaikh”, più diffusi tra le comunità agricole sedentarie, che godono degli stessi privilegi ed autorità dell ‘aristocrazia terriera, sostengono la loro discendenza dalla stirpe del Profeta e in alcune zone sono capi di forti congregazioni islamiche che esercitano un ruolo anche nell ‘organizzazione politica e sociale della tribù.I “mullah”, invece, svolgono un ruolo più legato alla tradizione mussulmana e hanno il compito di dirigere le preghiere e le scuole corani che nei villaggi, presiedono le cerimonie della collettività, matrimoni, funerali, riti di circoncisione e battesimi, un’usanza diffusa in Anatolia dai predicatori e missionari cristiani bizantini che si è conservata anche dopo la loro islamizzazione.
Santoni, sacerdoti e maghi
Tuttavia i personaggi più rappresentativi dell’originale integrazione tra le più antiche tra dizioni tribali e quelle mussulmane dei kurdi, sono i “sayyd”, considerati cane una sorta di santoni depositari della tradizione popolare e delle conoscenze coraniche che spesso possiedono capacità magiche e chiaroveggenti. A differenza degli altri religiosi non hanno residenze fisse e si spostano tra villaggi e accampamenti nomadi, mantenuti dalle comunità con offerte in prodotti agricoli e bestiame, per predicare ed insegnare a coltivare lo spirito, ma anche per curare malattie, propiziare raccolti e scongiurare disgrazie attraverso pratiche divinatorie o magiche nelle quali si servono di incantesimi ed esorcismi, amuleti e formule magiche, derivanti sia dalla tradzione preislamica, sia da quella mussulmana popolare.In alcune zone, inoltre, i rappresentanti della casta religiosa kurda sono a capo di sette islamiche medioevali di origine “sufista” ancora diffuse nelle zone agricole più povere del Kurdistan, came quelle dei “Qudiriyyah” e “naq shibaniyyah” le cui particolari concezioni possiedono anche una loro incidenza sociale tra gli strati più umili del la popolazione.Particolarmente interessante è, inoltre, un culto “satanico” diffuso nel nord del kurdistan a lungo combattuto dalle autorità musulmane, che probabilmente deriva da quello presente in Persia e Mesopotamia nella antichità tra le popolazioni indoeuropee e che rappresenta uno degli elementi culturali più remoti sopravvissuti tra i kurdi. Sebbene sia mescolato all’ islamismo e a credenze popolari di varia natura, questo culto possiede caratteristiche proprie del tutto diverse anche dalle sette esoteriche islamiche più particolari un tempo diffuse nell ‘Asia iranica. Questi misteriosi “adoratori del diavolo” , come vengono chiamati dalle altre popolazioni, concepiscono Satana non solo come sola potenza maligna che si oppone al bene, ma come protagonista della stessa creazione e strumento della volontà divina nel mondo.
Secondo tale concezione il diavolo contiene in se tutte le forze maligne e benigne che governano il mondo per volere del Dio Supremo e pertanto è oggetto di culto e di riti propiziatori nel corso dei quali Satana è incarnato da un pavone, animale sacro e rappresentazione della suprema regalità così come lo era nella più antica tradizione persiana.Anche questo è un elemento che contribuisce a cercare l’origine del complesso culturale e sociale di questa popolazione in epoche remote, probabilmente proprio a quelle antiche tribù idoeuropee che millenni or sono irruppero sia in occidente che in oriente e determinarono il corso della storia.Tenacemente legati alla proria cultura e società, questi presunti ultimi discendenti di quelle popolazioni continuano a voler essere i protagonisti della loro esistenza senza piegarsi a nessuna pressione che provenga dall’ esterno e da oltre un millennio si battono ininterrottamente tra le loro montagne con tutti i mezzi.